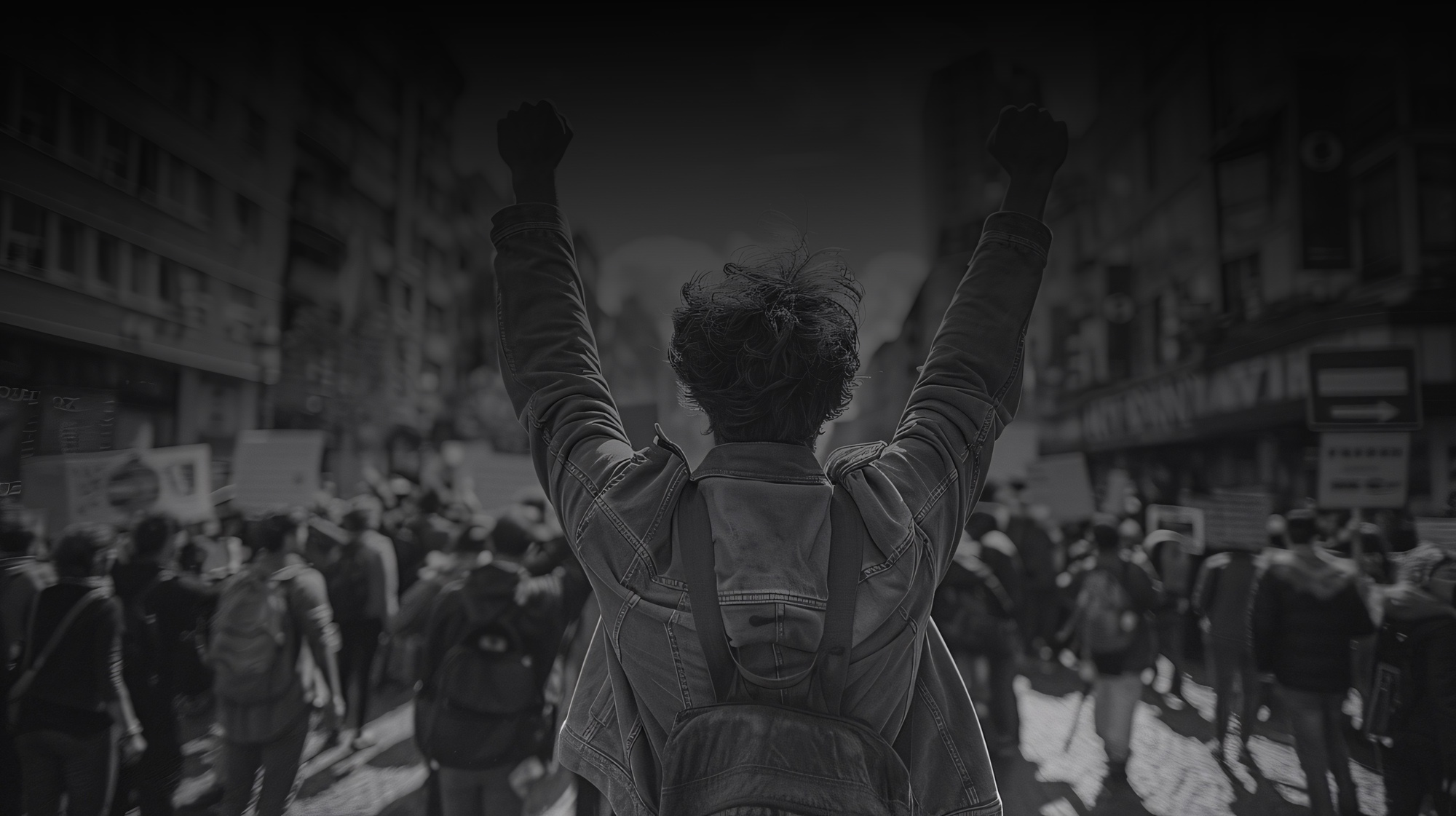
Oltre il sovranismo. Per l'Europa potenza
"Oltre il sovranismo" rappresenta una pietra miliare nel pensiero di ESI. Nel breve saggio si indica il percorso ideologico ma anche la soluzione pragmatica per arrivare all'Europa Potenza. Un processo ritenuto indispensabile per non soccombere nell'attuale epoca multipolare costituita da grandi potenze continentali, come USA, Cina, India e Russia.
I. OLTRE IL SOVRANISMO
Il sovranismo, nebulosa di idee più che compiuta dottrina politica, ha infiammato gli anni passati; trattasi di un fuoco ormai spento, in parte per consunzione, in parte per incapacità delle forze che ne erano portatrici. Ingeneroso sarebbe tuttavia liquidarlo come impostazione politica ingenua, puerile. C’erano aspetti esecrabili, quali per esempio, nel caso italiano, una grottesca germanofobia, con relativo sentimento anglofilo diffuso in molti settori di quell’area, l’attaccamento antistorico alla Costituzione del ’48, fino a sfociare nei richiami all’antifascismo e nell’esaltazione agiografica della cosiddetta “Prima Repubblica”. Una visione offuscata da un limitante economicismo che ha portato a dare assoluta preminenza alle questioni (pur importanti) relative alla moneta e ai conti, ma altresì venivano agitati temi degni di interesse. Il richiamo alla sovranità è suonato infatti come riferimento al primato della politica e dell’idea di Stato, in un epoca in cui questi sembravano, almeno nel Vecchio Continente, aver abdicato in favore della globalizzazione e dell’idea liberale (ma anche marxista) di un cosmopolitismo senza piú Stati. Benché il sovranismo sia stato agitato anche da forze di estrazione liberale - altro elemento equivoco di tale corrente - esso infatti vantava naturaliter una vis antiliberale e in campo politico, e in campo economico, ripudiando le ricette liberiste e affermando soluzioni di rottura.
L’aspetto in cui il sovranismo si dimostrava più in errore non era di poco momento, ossia quello di proporre il ritorno, in polemica con l’Unione Europea, agli Stati nazionali. Progetto miope, perché destinato a scontrarsi con la circostanza che, sebbene l’età degli Stati sia tutt’altro che tramontata - basti pensare agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia - a entrare in crisi é stato un tipo specifico di Stato, lo Stato nazionale europeo, il quale per dimensioni, demografia, capacità economiche e militari, non è più in grado, da solo, di confrontarsi con realtà di dimensioni continentali.
Del resto, quando si discorre di “sovranità”, occorre distinguere l’accezione giuridica da quella politica del termine. Se nel primo senso si fa riferimento a un dato meramente formale (l’originarietà del potere di uno Stato), il secondo significato attiene alla reale capacità di imporsi sulla scena internazionale: la differenza, per citare Dieter Grimm, tra “’potere’ nel senso di ‘avere il permesso di fare qualcosa’ e ‘potere’ nel senso di ‘avere la capacità di fare qualcosa’. Il diritto di autodeterminazione spetta ugualmente a tutti gli Stati, cionondimeno i rapporti di forza tra di essi differiscono” 1.
Ancora più perspicuo Marcelo Gullo, a cui si deve l’individuazione del fondamentale concetto di soglia di potere, identificata nel “quantum di potere minimo necessario al di sotto del quale cessa la capacità di autonomia di un’unità politica 2”. Infatti, “solo gli Stati che raggiungono la soglia di potere vigente in ciascun momento storico sono veri ‘soggetti’ della politica internazionale. Gli Stati che non raggiungono tale soglia di potere, anche se possono accedere a una grande prosperità economica, tendono inevitabilmente a diventare ‘oggetti’ della politica internazionale, cioè Stati subordinati” 3. Importante, infine, il rilevo del politologo argentino secondo cui “la soglia di potere necessaria affinchè uno Stato non cada nella subordinazione è sempre in rapporto con il potere generato dagli altri Stati del sistema internazionale. L’aumento considerevole del potere di una o più unità politiche provoca quindi una variazione sostanziale della soglia di potere di cui le altre unità politiche hanno bisogno per non finire nello stadio di subordinazione 4”. E non può essere negata la circostanza che, oggi, tale soglia si attesti al livello di entità statuali di rango continentale o subcontinentale.
Attualmente, gran parte degli Stati europei é legata all’Alleanza atlantica a guida statunitense; appartenenza che, se dalla Guerra Fredda a oggi ha consentito ai primi di destinare un’aliquota tutto sommato modesta dei loro bilanci alle spese militari, potendo riservare maggiori risorse al finanziamento dello Stato sociale, ha avuto come “costo” la posizione di subordinazione rispetto agli Stati Uniti e alle loro linee strategiche. La Nato, infatti, dopo la fine del Patto di Varsavia, ha visto ridisegnata la propria missione: da organizzazione tendenzialmente difensiva a braccio armato della superpotenza americana, e adoperata per le più disparate operazioni di esportazione della democrazia: dalla Serbia all’Iraq, fino alla Libia.
Appartenere all’Occidente, al netto della formale adesione all’Alleanza atlantica, comporta delle conseguenze precise: non solo subordinazione strategica, ma altresì culturale e simbolica a quanto prodotto oltreoceano, dall’American way of life alla cultura woke, nonché una stretta dipendenza per quanto riguarda l’aspetto tecnologico: si pensi alle piattaforme digitali e ai cloud di archiviazione dei dati, tutti localizzati negli Stati Uniti.
Con la guerra in Ucraina tale condizione si è manifestata apertamente. Tale conflitto è da inquadrarsi in una secolare strategia angloamericana (rileggersi Mackinder) volta ad impedire la congiunzione tra Europa (e segnatamente la Germania) e la Russia.
L’influente politologo americano George Friedman, parlando al Chicago Council of Global Affairs nel 2015, dichiarava: “l’interesse primario degli Stati Uniti, per il quale abbiamo combattuto le guerre di un secolo consiste nell’impedire la saldatura fra la Germania e la Russia, perché unite rappresentano l’unica forza in grado di minacciarci. Per gli Stati Uniti la paura fondamentale è che il capitale finanziario e la tecnologia tedeschi si saldino con le risorse naturali e la mano d’opera russe. È l’unica alleanza che fa paura agli Stati Uniti, cerchiamo di impedirla da un secolo” 5.
In quest’ottica è da inquadrare il regime change a Kiev nel 2014 e la strumentalizzazione dell’Ucraina in funzione antirussa, sino al suo paventato ingresso nella Nato. Come aveva ben compreso Zbigniew Brzezinski, già Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in un suo libro del 1997 ,“se Mosca riprendesse il controllo sull’Ucraina, con i suoi 52 milioni di abitanti e le sue principali risorse, nonché il suo accesso al Mar Nero, la Russia riacquisterebbe automaticamente i mezzi per diventare un potente stato imperiale, che abbraccia Europa e Asia” 6. Da qui la “trappola” 7, come ha scritto Marco Tarchi, tesa alla Russia, che ha svolto in commedia il ruolo che le era stato preparato, quello di brutale violatore della sovranità altrui, con la conseguenza di riportare le relazioni con l’Europa indietro di decenni, di rinsaldare i legami atlantici degli Stati europei, e di comportare un’espansione della Nato stessa, con l’ingresso di Svezia e Finlandia. Interessante in quest’ottica la sorte del gasdotto Nord Stream: ufficialmente ignoti gli autori del sabotaggio, non si può dimenticare la lettera con cui alcuni senatori repubblicani statunitensi minacciarono pesanti conseguenze per le imprese europee coinvolte nel progetto 4.
Pare che gli americani, più che gli europei, abbiano consapevolezza delle potenzialità derivanti dall’unità degli Stati del Vecchio Continente, e di una loro integrazione con la Russia.
II. PER L’EUROPA POTENZA
I guasti dell’Unione Europea sono sotto gli occhi di tutti, e non meritano alcuna indulgenza. Non si tratta, invero, della sterile polemica contro i “burocrati” o i “tecnici” (ogni istituzione ne ha bisogno), quanto nella pretesa di fondarsi sul mercato e sui diritti. Non v’è dubbio, infatti, che il processo di integrazione sia nato, col beneplacito degli Stati Uniti, dopo il varo del Piano Marshall e la nascita del Patto Atlantico, per creare un’area di libera circolazione delle merci in quella parte di Continente sotto l’egida occidentale.
In questo senso va anche inquadrata la progressiva ammissione di nuovi Paesi membri dopo la caduta del Muro. Scelta senz’altro funzionale all’Europa mercato, ma non all’Europa potenza. L’allargamento inopinato dell’Unione infatti, ha indebolito la coesione e la capacità decisionale di questa, nell’interesse precipuo degli Stati Uniti. Notava ancora Brezinski: “un’Europa allargata e una Nato allargata serviranno gl’interessi a breve e a lungo termine della politica statunitense. Un’Europa allargata estenderà il raggio dell’influenza americana senza creare, allo stesso tempo, un’Europa così politicamente integrata che sia in grado di sfidare gli Stati Uniti in questioni di rilievo geopolitico, in particolare nel Medio Oriente” . In quest’ottica può cinicamente ritenersi positivo il recesso dall’Unione del Regno Unito, da sempre “cavallo di Troia” degli Stati Uniti, come aveva ben compreso De Gaulle; uno Stato che non aveva visto nella costruzione europea null’altro che un mercato comune e da sempre refrattario a maggiori forme di integrazione.
Si stagliano quindi due visioni dell’Europa. Una, quella che anima le principali forze politiche e la totalità delle posizioni intellettuali accettate, nonché le attuali istituzioni europee, é quella di un’Europa che nasca per rinnegare le nazioni, i confini, il concetto stesso di sovranità e fungere da tappa verso la globalizzazione e lo Stato mondiale. Trattasi di un’Europa atlantica, occidentale, asservita all’ideologia dei diritti dell’uomo e ai dogmi dell’economia di mercato, e nella quale si trovano concordi liberali e post-marxisti. Se ne ha un eloquente saggio leggendo l’art. 3 par. 5 del TUE (Trattato sull’Unione europea); ove si afferma che “l’Unione (…) contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.” E ancora, a mente dell’art. 21 par. A let. e), essa opera per “incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali”. Cosa c’è di “politico” in tutto questo, laddove con ciò si intende finalizzato alla conservazione di una comunità politica e al perseguimento dei suoi interessi? L’altra concezione, invece, intende superare gli Stati nazionali per costruire una sovranità europea, con dei confini e una volontà di affermazione. Un’Europa indipendente dagli Stati Uniti, capace di rappresentare un elemento di equilibrio nelle relazioni internazionali. Come ha scritto Günter Maschke: “chi oggi parla di Europa deve anche dire chiaramente se intende servire 'l'universalismo' o il 'grande spazio’, per riprendere due concetti cari a Carl Schmitt; se desidera la dissoluzione del mondo in una sola e unica unità pacificata, nella quale non vi sarebbe altro che un'unica politica interna mondiale, dove la pace sarebbe mantenuta con l'aiuto di espedienti di tipo poliziesco o se desidera un'organizzazione regionale dei poteri del mondo, organizzazione mediante la quale i popoli collaborerebbero tra loro, in serenità e nell'indipendenza reciproca"9.
É proprio Carl Schmitt, già nel 1928, a preconizzare un’unità europea contrapposta all’universalismo della Società delle Nazioni. Così si esprimeva il giurista tedesco: “se questa Europa non deve essere semplicemente una povera decorazione, ma un'unità politica, cioè indipendente dai mutevoli interessi economici e dalle congiunture, duratura e capace di azione, allora essa sarebbe non meno che una nuova potenza mondiale. La sua semplice esistenza produrrebbe nuovi raggruppamenti di amico e nemico, e si dovrebbe vedere se le potenze mondiali esistenti, in particolare il sistema di Stati anglosassone, abbiano interesse a lasciar sorgere accanto a loro una formazione politica che abbia forza ed autonomia propria”10.
L’Europa potenza é il progetto di coloro che credono nel primato della politica estera, e anzi eleggono quest’ultima a “vera” politica, animati dal convincimento che oggi, l’unica via per le nazioni europee di sopravvivere, di tutelare i propri interessi e i propri modi di vita, nonchè di rimanere - rectius ritornare - nella storia, sia quello dell’unità politica continentale. Una via vieppiù imposta dalle grandi sfide relative all’approvvigionamento di risorse, all’indipendenza tecnologica (si veda il tema dei semiconduttori o quello della sovranità su dati e cloud), oltre, ovviamente all’aspetto strategico, in un momento in cui gli interessi americani ed europei sembrano divaricarsi.
III. FARE GLI EUROPEI
Un problema che emerge a questo riguardo è quello dell’omogeneità, aspetto di non poco momento quando si parla di unità politica. Secondo E.W. Böckenförde “è la sola in base alla quale risulta possibile un’organizzazione democratica dello Stato che si costruisca su un’uguaglianza stricto sensu dei diritti di cooperazione politica; i cittadini, nelle questioni fondamentali attinenti l’ordinamento politico, si sanno ‘uguali’ e concordi e quindi esperiscono e percepiscono i concittadini come persone, da un punto di vista esistenziale, né diverse, né straniere, rendendosi su tal base disponibili a compromessi e ad una leale accettazione delle decisioni assunte a maggioranza” 8.
Una delle critiche più diffuse alla possibilità di una unità europea, mossa anzitutto da esponenti della dottrina tedesca (nota sul punto è la posizione di Dieter Grimm 9), è che farebbe difetto l’esistenza di un “popolo” europeo, quel “we the people” che possa innescare la miccia di un potere costituente continentale. In realtà, più che di “popolo”, occorrerebbe discorrere di nazione, ossia, sempre per citare Böckenförde, “il gruppo di uomini il quale, aggregandosi e delimitandosi politicamente, è cosciente di se stesso come dimensione politica ed entra nella storia come tale” 11. Specie chi sia memore dell’insegnamento di Giovanni Gentile 10 12, ha contezza che non è la nazione a creare lo Stato, ma lo Stato a creare la nazione, e in tal senso depone la storia di Stati europei come l’Italia e la Francia; in sintesi: la nascita della comunità politica dei cittadini non è un prius ma un posterius rispetto alla formazione della compagine statale. Occorre quindi “forzare” la realizzazione di forme di integrazione politica e solo in seguito si avrà, ancorchè al costo di non pochi sacrifici, la creazione di un demos continentale, con una opinione pubblica, partiti, sindacati.
Non va, nondimeno, sottovalutato il ruolo che la partecipazione politica può assolvere ai fini di quella che Rudolf Smend ha definito “integrazione funzionale” 11: il voto, le elezioni e gli altri istituti di partecipazione possono concorrere alla creazione dell’unità. In questo senso l’importanza dell’elezione diretta degli organi istituzionali e l’instaurazione di un’autentica democrazia su base continentale, con l’effetto per il quale da una parte verranno relativizzati gli interessi dei singoli Stati, dall’altra potrà crearsi un comune senso di appartenenza intorno a interessi e un destino comuni. Questo serve altresì a revocare in dubbio la posizione di chi ravvisa nell’Europa unita il rischio che, per suo tramite, emerga una egemonia di taluni paesi a detrimento di altri. Invero, questo è proprio ciò che è favorito dall’attuale configurazione dell’Ue, a base intergovernativa, ove gli Stati più forti riescono a imporre il loro peso.
Vi è poi l’annosa questione dell’identità europea: radici indoeuropee, classiche, cristiane, ecc. Il rischio è quello di perdersi in disquisizioni oziose. Due sono le cose da considerare. La prima è che nelle radici dell’Europa è possibile ravvisare tutto e il suo contrario, ciò che conta è una decisione su quali elementi del proprio retaggio seguire e valorizzare: una decisione sul futuro più che sul passato. In secondo luogo un’identità europea non potrà che nascere in contrapposizione polemica all’altro da sé, e segnatamente all’Occidente: la vera Europa dovrà decidersi per l’alterità rispetto a questo, concetto concepito primariamente proprio contro l’Europa stessa. Federico Chabod ha scritto: “Coscienza europea significa infatti differenziazione dell’Europa, come entità politica e morale, da altre entità, cioè, nel caso nostro, da altri continenti o gruppi di nazioni; il concetto di Europa deve formarsi per contrapposizione, in quanto c’è qualcosa che non è Europa, ed acquista le sue caratteristiche e si precisa nei suoi elementi, almeno inizialmente, proprio attraverso un confronto con questa non Europa. (…) il fondamento polemico è essenziale” 12.
Ciò che è certo è che l’omogeneità del continente non può essere ricercata a partire da astratti “valori” quali quelli proclamati dall’art. 2 del TUE (quelli del “rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”): in primis perché essi, se possono essere figli di una certa cultura europea, evidentemente di stampo razionalista e individualista, non esprimono nulla di europeo. Come ha osservato a riguardo Alain de Benoist “non sono dei valori specificamente europei dal momento che possono essere reclamati da chiunque nel mondo. È un'affermazione abusiva dire che sono i fondamenti dell'Unione Europea. Sono valori universali, cioè senza un rapporto diretto con le situazioni concrete e dunque vuoti di senso” 13. Secondariamente, pensare di fondare l’unità politica sul richiamo ai valori è quantomeno controproducente. In difetto di un fondamento razionale e della genericità degli stessi, si prestano a essere letti e interpretati nelle maniere più diverse, animando il conflitto in luogo della condivisione (chi può dire cosa sia più adeso alla “dignità umana” in materia di eutanasia: preservare la vita del paziente o concedergli una “morte dignitosa”?). Il contenuto di tali proclamazioni finirebbe col coincidere con quello attribuito loro da chi abbia la forza di impossessarsene.
IV. QUALE EUROPA?
L’Europa che vogliamo non esiste, e non esisterà mai finchè ci si opporrà a qualsiasi forma di integrazione che non coincida col figurino che si ha in mente. Pensare di attendere la dissoluzione dell’UE per poi dar vita ad un soggetto conforme ai propri desideri non è solo illusorio, ma profondamente sbagliato. Occorre cogliere con attenzione i tentativi di evoluzione posti in essere anche da soggetti e in nome di disegni distanti da quelli dell’autentica Europa potenza. Quella da perseguire è una via pragmatica, che sappia innestarsi sulle strutture e i processi esistenti, contribuendo semmai ad accelerarli e indirizzarli nel giusto senso.
Che fare, quindi? Come detto testè, l’attuale Unione a 27 non è suscettibile di evolversi nel senso dell’unità politica; vi è quindi necessità che si formi un’avanguardia, un “nucleo duro” dell’integrazione europea, da costituirsi a “cerchi concentrici” - per adoperare la formula di Jaques Delors - costituito da quegli Stati, sufficientemente omogenei tra loro per condizioni politiche, sociali e culturali, disposti ad attuare le opportune forme di collaborazione nonché a cedere aliquote di attribuzioni sovrane. Un primo passo potrebbe essere, alla stregua di quando fatto con l’unione monetaria, la configurazione di un novero di Paesi determinato a dar vita a una struttura in grado di incidere realmente sulle questioni di difesa e politica estera, con il superamento del voto all’unanimità in seno al Consiglio dell’Unione. Gli Stati coinvolti potrebbero essere i sei fondatori più altri dell’Europa occidentale, da Lisbona a Vienna. Troppo legati agli Stati Uniti e refrattari ad andare oltre un mercato unico gli altri Stati dell’Est e del Baltico, i quali in buona parte danno vita a quel “cordone sanitario” antirusso che prende il nome di Intermarium,ma che tuttavia dovranno rimanere integrati sotto il profilo economico, nella prospettiva di un loro successivo coinvolgimento anche sotto l’aspetto più schiettamente politico.
Verrebbe così a crearsi, sempre avendo di mira soluzioni realistiche, una struttura militare europea, senza immediata necessità di recesso dall’Alleanza atlantica, che tuttavia si spingerebbe ben oltre quanto finora fatto in materia di politica di difesa comune, superando le limitazioni osservate in ottemperanza ai diktat statunitensi, e riassunte nelle “3d” a suo tempo dettate da Madeleine Albright nei termini di “no decoupling” (nessuna dissociazione dall’Alleanza Atlantica), “no duplication“ ( delle capacità), “no discrimination” (dei soggetti non Ue, come la Turchia). Una difesa europea dovrà invece acquisire una propria soggettività e obiettivi strategici propri, dotandosi di strutture e linee di comando autonome. Senz’altro questo non troverà il favore della potenza d’oltreoceano, la quale tuttavia potrà concentrare le forze nel (più) vitale scacchiere del Pacifico in chiave anti-cinese e giovarsi di una minore spesa per sostenere la difesa degli europei, i quali quindi si assumeranno l’onere di investire massicciamente nell’ambito militare. Per fare ciò che necessario che gli Stati del Vecchio Continente si liberino dagli impedimenti derivanti da decenni di senso di colpa e di vuoto pacifismo, recuperino le smarrite virtù militari e una sana volontà di potenza, facendosi carico in misura crescente della propria difesa, coi relativi costi. Obiettivo di lungo termine sarà l’elaborazione di una “Dottrina Monroe” europea, che preservi lo spazio continentale dagli interventi di potenze esterne, necessità resa sempre più stringente da circostanze recenti come le mire manifestate da Donald Trump sulla Groenlandia.
Concentrarsi sull’elemento della “potenza” non significa trascurare, con cieco cinismo, i temi economici. Sotto questo profilo sono da rilevare gravi squilibri: in primo luogo una moneta unica (per 19 Stati) in un’area valutaria non ottimale in difetto di politiche sociali, norme fiscali, strumenti perequativi comuni, con i singoli Stati che rimangono destinatari delle aspettative di benessere dei cittadini, con l’effetto, come ha scritto Böckenförde, di una “scissione della cura del bene comune”14 Anche qui, la soluzione non è il ripristino delle monete nazionali, bensì una maggiore integrazione, con la creazione di un autentico bilancio comune e politiche perequative interne. E ancora: la Banca centrale Europea è attualmente un’istituzione “indipendente”, asseritamente “apolitica” (come se l’opzione per l’indipendenza non costituisca a sua volta una scelta politica) e votata anzitutto alla stabilità dei prezzi, nel preminente interesse degli investitori finanziari. Fondamentale sarebbe porla sotto il controllo della Commissione (e, in futuro, di un governo europeo democraticamente legittimato) e rivedere i suoi obiettivi nel senso della crescita e del raggiungimento della piena occupazione. Questo non piacerà sicuramente alla Germania, conformemente ai cui desiderata l’Unione monetaria è stata costruita, ma i tedeschi dovranno decidersi: assumersi le responsabilità (e i costi) derivanti dalla loro condizione nei confronti dell’intero Continente, oppure rimanere un gigante economico ma condannato all’insignificanza in termini strategici. Inoltre, occorre iniziare a pensare alla moneta unica non solo in riferimento alle sue indubbie criticità bensì, nelle more di un’auspicabile, e strutturale, risoluzione delle stesse, anche come strumento strategico. L’euro non è riuscito finora a intaccare la posizione del dollaro quale valuta internazionale di riferimento; eppure i vantaggi di una moneta diffusa a livello internazionale, quale strumento di pagamento e valuta di riserva sono indubbi: da una parte gli introiti derivanti dal signoraggio, ossia dall’emissione di banconote, dall’altra consente agli operatori della propria area valutaria di riferimento di giovarsi di tassi d’interesse inferiori. Insomma un veicolo di potenza, ma che per essere tale abbisogna di una politica forte alle spalle. Vi è pertanto da rimanere sconcertati nell’osservare le polemiche, mosse da certi ambienti “sovranisti”, contro il Franco CFA, che invece rappresenta uno strumento fondamentale per estendere l’area valutaria dell’Euro al continente africano. Parimenti, occorre rendere l’emissione di bonds europei, da intervento emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid 19 – Agostino Carrino ha scritto che così “la politica dell’Unione europea si è per la prima volta orientata nel senso della ‘statualità’” 15 - a misura strutturale al fine di costituire un debito comune da impiegare in investimenti strategici quali la difesa, l’innovazione tecnologica, ecc.
V. L’EUROPA POLITICA
Ma quale dovrebbe essere la forma politico-istituzionale più idonea a perseguire un disegno di indipendenza europea? Occorre anzitutto premettere che il necessario realismo deve indurci ad avvalerci delle possibilità che ci sono offerte senza ricorrere a disegni utopistici privi di utilità pratica, nonché a essere consapevoli che la costruzione dell’Europa politica sarà un processo graduale e non lineare. Formule spesso evocate, dal tenore equipollente, sono quelle che fanno riferimento a l’”Europa delle Patrie, dei Popoli, delle Nazioni, ecc.”. È d’obbligo tuttavia notare, che questa Europa esiste già ed è quella che abbiamo sotto gli occhi, nella quali gli Stati membri sono i signori dei Trattati, e nella quale il metodo intergovernativo la fa da padrone, trovando nel Consiglio dell’Ue l’organo nel quale esso si esprime. Sovente, sempre allo scopo di “salvare capra e cavoli”, nell’intento cioè di auspicare la costituzione di una soggettività politica europea e contestualmente salvaguardare la sovranità degli Stati, si fa riferimento all’ipotesi di una “confederazione”, nell’errato convincimento, peraltro, che essa rappresenterebbe un minus al confronto con l’attuale assetto. Orbene, se si guarda per esempio alla confederazione degli Stati Uniti, esistita fino al 1787, può notarsi come essa disponesse di un proprio governo, di un presidente eletto direttamente, di un suo ius belli e di un esercito. Insomma, non proprio l’Europa minimal che molti hanno in mente. Carl Schmitt, trattando, nella parte quarta della sua Dottrina della costituzione, proprio questo tema, ha scritto che “in una confederazione coesistono due specie di esistenza politica: l'esistenza complessiva della federazione e l'esistenza singola dei membri della federazione. Le due specie di esistenza politica devono necessariamente continuare a coesistere, finché deve continuare ad esserci una federazione” 16, ravvisando quindi una tensione - egli parla di “antinomia” 17 - tra l’esistenza della confederazione e quella degli Stati, coi loro interessi, i loro egoismi, le divisioni tra loro, i rischi di condizionamento da parte di soggetti esterni. Schmitt ritiene che l’omogeneità tra gli Stati membri possa ovviare a questa criticità, tuttavia chiarendo che “il concetto di una unità politica composta di Stati, permanente e che non abbandona il suo fondamento pattizio appare comunque come qualcosa di sommamente contraddittorio” 18. Emerge qui tutta la precarietà di tale costruzione in due aspetti principali: in primis che soggetti della politica internazionale sono gli Stati e solo questi. Un soggetto ibrido come una confederazione, tutto da vedere nella sua concreta realizzazione, non riuscirebbe – e veniamo così al secondo punto – a garantire quella “unità di decisione universale su un territorio” 19 per citare Hermann Heller, che è appunto caratteristica precipua della statualità, rimanendo la sovranità “divisa” tra livello statale e confederale e risolvendosi con la secessione dello Stato, ovvero la dissoluzione della confederazione, nel caso si pervenga a una frattura insanabile. Ciò che serve è un vero e proprio Stato, federale, che quindi pur attribuisca ampie competenze agli Stati (non più sovrani) membri, ma pur sempre Stato. In tal guisa sarà possibile attenuare la spinta centrifuga dei singoli Paesi e il loro peso specifico nelle decisioni a vantaggio della volontà del popolo europeo, e adottare quelle misure (si veda ad esempio il bilancio unico) cui nell’attuale configurazione taluni Stati si oppongono. Costituzione europea? Occorre a proposito tenere in considerazione che una Costituzione non può essere disgiunta dall’unità politica, ossia dallo Stato. Tale condizione può preesistere alla (nuova) costituzione, come nel caso della Rivoluzione francese, ovvero venire a esistenza unitamente a questa, come nel caso di quella americana. Il tentativo di inizio anni Duemila, poi fallito, di dotare l’Europa di una costituzione, chiamava in causa indebitamente questo alto concetto, poichè in tale occasione non si dava vita ad alcuna unità politica, e l’Unione rimaneva un soggetto costruito secondo la grammatica del diritto internazionale, (tale “Costituzione” era adottata nella forma di un trattato), donde, per esempio il diritto di recesso degli Stati, che rimanevano i veri domini della costruzione eurounitaria. Inoltre, il soggetto costituente non era il popolo, ma una “Convenzione” di personalità che non avevano ricevuto alcun mandato specifico dai cittadini europei. Altro elemento distonico rispetto alla struttura e alle funzioni di una costituzione, e che infatti ne ha consentito il rapido “riciclo” nel Trattato di Lisbona, era quello di contenere una fitta disciplina di dettaglio, riferita essenzialmente alle materie del mercato e dell’intervento pubblico nell’economia, con il chiaro obiettivo di incorporare una (non nuova) “costituzione economica” di stampo ordoliberista. Come ha notato Dieter Grimm, “le costituzioni si limitano a regolare formalmente e materialmente il processo decisionale democratico, lasciando le decisioni stesse alla politica, che le prende in base alle preferenze espresse dagli elettori attraverso il voto. I trattati europei, invece, non sono caratterizzati da una limitazione di questo tipo. Sono loro stessi a prendere decisioni politiche. Sono pieni di materie e questioni che in qualsiasi Stato sarebbero regolate sul piano della legge ordinaria, in modo tale da poter essere modificate in qualsiasi momento con una decisione a maggioranza. Nell’UE, invece, tutte queste norme assumono il rango costituzionale dei Trattati e sono quindi rese immuni dal processo democratico” 20. Occorre pertanto superare tale assetto (consci che la questione non è tecnica, ma politica) e rimettere alla discrezionalità del decisore democraticamente legittimato tali scelte, che non possono essere “congelate” una volta per tutte in un atto “rigido” com’è una costituzione.
VI. COME ARRIVARCI
Sarà un processo graduale, certo, nel corso del quale occorrerà accontentarsi anche dei più flebili passi compiuti nella giusta direzione, quantunque realizzati da soggetti e in nome di idee e finalità che non godono del nostro favorevole apprezzamento. Non saranno sfuggite a chi legge le importanti dichiarazioni rese dal Presidente francese Macron in ordine alla “morte cerebrale della Nato”, o ancora il progetto di “autonomia strategica” da questi lanciato. Occorrerà verificare che l’inquilino dell’Eliseo non dissimuli, alla maniera sovente propria di certi francesi, le velleità di grandeur dietro un’impalcatura “comunitaria”. Ove invece tali intenzioni fossero sincere, bisognerà seguirle senza indugi, anche al costo di accettare un’egemonia francese – la Francia comunque, oltre ad essere l’unico Stato dell’Ue dotato di armi nucleari e di un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, è l’unico a possedere una qualche visione strategica – sulla costituenda difesa europea. Una volta messa in movimento la macchina dell’Europa potenza potrebbero svilupparsi dei riflessi incondizionati tali da sfuggire agli attuali esponenti dell’establishment dell’Unione.
Le avanguardie dell’Europa potenza, che dovranno rettamente inquadrare tale disegno in una più ampia visione del mondo alternativa al liberalismo e al sistema occidentale, dovranno agire, nei limiti del possibile, al fine di indirizzare gli sforzi compiuti nel senso di una maggiore integrazione europea verso l’obiettivo di un’accresciuta autonomia continentale. In secondo luogo dovranno svolgere, presso gli ambienti non conformisti, un’efficace azione volta a convincere i più, animati da ideali genuini ma ancora legati alla forma dello Stato-nazione, della bontà di tale disegno. Dai ranghi, oggi sparpagliati, del cosiddetto sovranismo possono trarsi buoni sostenitori della causa dell’indipendenza europea, vi è solo da aprire loro gli occhi e incoraggiarli a evolvere la propria visione delle cose. Inoltre, appare opportuna un’azione volta a influenzare i partiti di destra, nazional-populisti e simili, i quali sostengono, seppur spesso confusamente, battaglie positive in difesa dei confini, dell’identità, contro il globalismo: la sfida sarà quella di condurli a volgere queste rivendicazioni in chiave europea.
L’Europa potenza è ciò che oggi serve per consentire a centinaia di milioni di europei di sopravvivere alle sfide mondiali. Questa dimensione non rappresenterà la fine, bensì la rivitalizzazione delle singole nazioni europee, entità da conservare e non da disperdere, in un mondo finalmente multipolare e segnato dall’esistenza di plurimi spazi politici tendenzialmente “chiusi”, cioè, nè più nè meno, indipendenti. Un’Europa di nuovo sulla scena mondiale può favorire il sorgere di questo nuovo Nomos della Terra.
2 M. GULLO, La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones (2008), trad. it. di A. Boccuti La costruzione del potere. Storia delle nazioni dalla prima globalizzazione all’imperialismo statunitense, Vallecchi, Firenze, 2010, p. 55.
3 Ivi, p. 56 (corsivo aggiunto).
4 Ibidem
5 L’intervento è agevolmente reperibile sulla piattaforma youtube.
6 Z. BRZEZINSKI, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategics Imperatives, Basic Books, New York, 1997, p. 46.
7 M. TARCHI, La trappola, in Diorama Letterario, gennaio-febbraio 2022.
8 Z. BRZEZINSKI, op. cit., p. 199.
9 G. MASCHKE, Unità del mondo e Grande spazio europeo, in L. SOREL, R. STEUCKERS, ID., Idee per una geopolitica europea, pp. 93-94.
10 E. W. BÖCKENFÖRDE, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes (1986), trad. it. di M. Nicoletti e O. Brino, Il potere costituente del popolo, in ID., Stato, costituzione, democrazia, cit., p. 121.
11 G. GENTILE, Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica, Sansoni, Firenze, 1946, p. 57.
12 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), trad. it. di F. Fiore e J. Luther, Costituzione e diritto costituzionale, Giuffrè, Milano,1988.
13 F. CHABOD, Storia dell’idea di Europa, Laterza, Bari, 1961, p. 23.
14 E. W. BÖCKENFÖRDE, Welchen Weg geht Europa? (1997), trad. it. di M. Carpitella Dove sta andando l’Europa?, in ID. Diritto e secolarizzazione, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 183.
15 A. CARRINO, Sei verità sul recovery found, in Charta Minuta, www.farefuturofondazione.it, gennaio 2021.
16 C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), trad. it. di A. Caracciolo, Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, p. 484.
17 Ibidem.
18 Ivi, p. 489.
19 H. HELLER, Politische Demokratie und Soziale Ömogenität (1928), trad. it. di U. Pomarici, Democrazia politica e omogeneità sociale, in ID. Stato di diritto o dittatura? E altri scritti (1928-1933), Editoriale Scientifica, Napoli, p. 10.
20 D. GRIMM, Europa Sovrana?, cit.

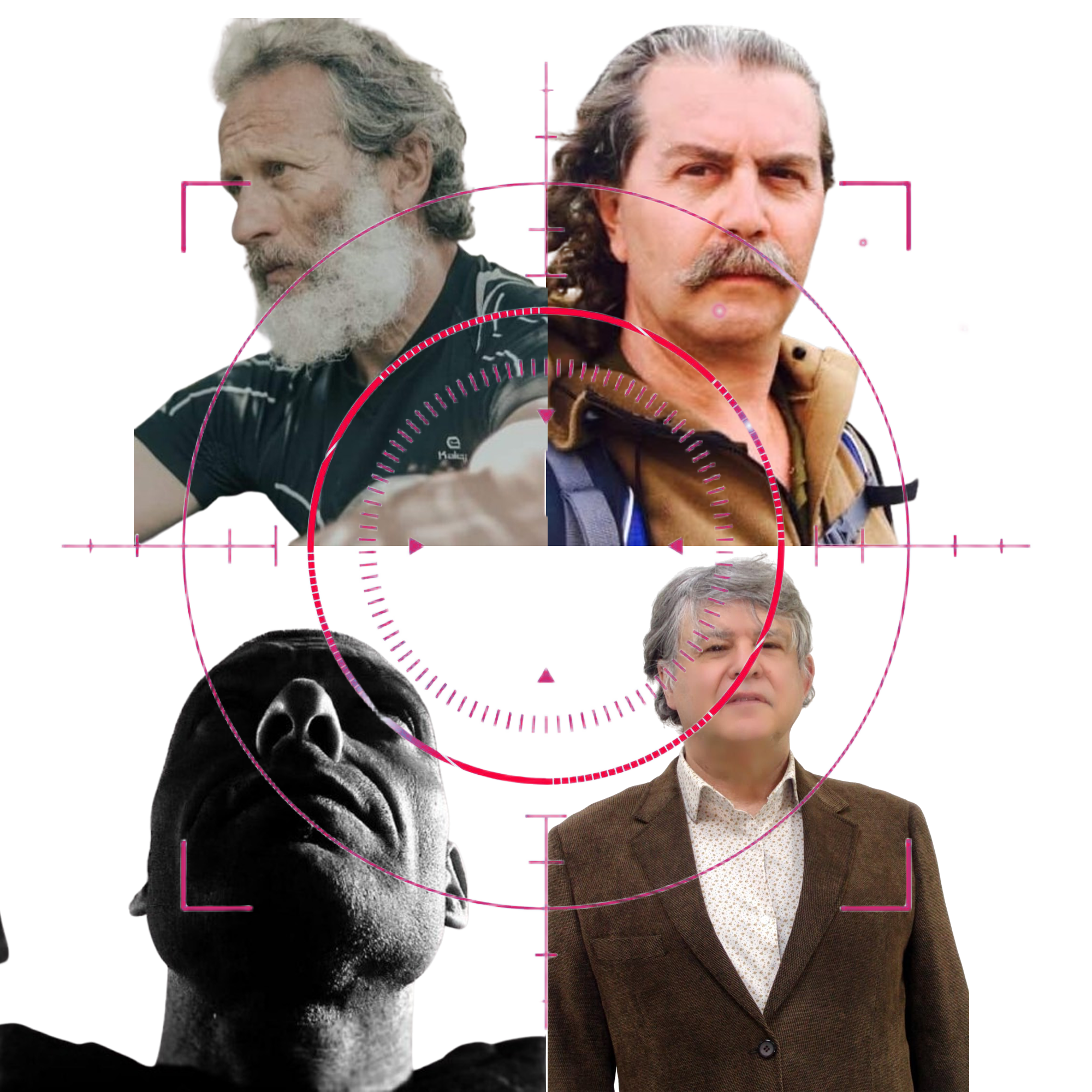
Ti piace nostro Manifesto?